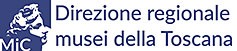Fornire un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti è il quarto obiettivo di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. Se consideriamo che la possibilità di erogare e di ricevere un’istruzione, ancor più se di qualità, è questione che si lega strettamente alle modalità di accesso al sapere, ciò che viene sostenuto è l’impegno a garantire la massima accessibilità della cultura, senza limitazioni che possano derivare dall’appartenenza a un determinato ambiente socio-economico, a un genere, a un contesto geografico. Per questo motivo, propongo una breve riflessione sull’importanza dell’accessibilità del sapere che si intreccia alle vicende che hanno portato all’istituzione della Biblioteca del convento (oggi Museo) di San Marco.
Il desiderio di un sapere che fosse a disposizione di tutti era comune fra gli umanisti a partire dalla seconda metà del Trecento: prima ancora che la diffusione della stampa a caratteri mobili facilitasse la circolazione dei libri e, di conseguenza, anche della cultura in Europa, questi uomini impegnarono gran parte della loro vita a ricercare antichi codici da studiare, confrontare, scambiare, discutere e riportare, con le armi della filologia, alla versione quanto più vicina all’originale. Il senso di questo lavoro risiedeva nella volontà di restituire alla comunità (una comunità, s’intende, ancora elitaria) quell’antico patrimonio di sapere, emendato da tutte le parti non pertinenti che nei secoli avevano contribuito addirittura a stravolgerne il significato. Si potrebbe definire già questa un’importante operazione di accessibilità culturale.

Quando poi si pensa che molti di questi uomini di lettere erano riusciti a mettere insieme delle straordinarie raccolte librarie personali a costo di lunghe ricerche e cospicui esborsi di denaro, e che erano soliti prestare e scambiare i propri codici, convinti che la cultura potesse fiorire non solo dallo studio personale ma anche dal confronto tra studiosi e dalla circolazione dei testi, non stupisce il loro desiderio di veder realizzati luoghi che tutelassero questo patrimonio di sapere, nella sua componente materiale e immateriale, e che lo rendessero anche maggiormente fruibile. Occorrevano delle biblioteche diverse da quelle dei grandi centri monastici, la cui accessibilità era limitata ai soli religiosi e la cui funzione era di fatto quella, come affermava Umberto Eco, “di non far leggere”, o meglio di controllare la diffusione di quel sapere che per secoli era stato accuratamente conservato. Occorreva dunque una nuova idea di biblioteca, dove la conservazione avesse come obiettivo la diffusione del sapere: era questa, nei sogni degli umanisti, la biblioteca pubblica, accessibile cioè anche ai laici e non solo ai religiosi.
Già nel 1362 Francesco Petrarca aveva espresso il desiderio di destinare ad uso pubblico la propria raccolta offrendola alla città di Venezia. Ma fu a Firenze, nel convento di San Marco, che il sogno di una biblioteca pubblica si concretizzò intorno all’eredità di un umanista fiorentino, Niccolò Niccoli, e alla lungimiranza della famiglia Medici.
Quando il Niccoli iniziò a preoccuparsi di quello che sarebbe stato il destino dei propri libri dopo la sua morte, aveva probabilmente ancora fresco il ricordo della dispersione della biblioteca privata del grande Coluccio Salutati, i cui preziosi testi erano stati prontamente rivenduti dai figli senza pentimenti. Come ricordava Poggio Bracciolini nell’orazione funebre dedicata al Niccoli:
Il nostro Niccolo […] decise diversamente per questo prezioso patrimonio, che per essere messo insieme era costato tanto tempo, tanto denaro, e tanta fatica. Volle che non fosse venduto, che non finisse in una dimora privata, che non fosse lasciato all’uso e all’arbitrio di uno solo. Né volle che fosse chiuso in una biblioteca privata. Volle che fosse offerto all’utilità pubblica, al pubblico bene, in un luogo aperto a tutti, dal quale tutti gli amanti delle lettere, come da un fertile campo, potessero cogliere il frutto ricchissimo del sapere. (Poggii Florentini, Opera, 1538, trad. E. Garin, 1999, p. 20)
In un primo testamento del 1430 il Niccoli indicò come luogo deputato il monastero di Santa Maria degli Angeli, poi cambiò idea e nel 1437, a un passo dalla morte, fece redigere un nuovo testamento dove lasciava agli esecutori testamentari la facoltà di decidere la destinazione della ricca raccolta. Raccolta gravata peraltro da vari debiti, che immaginiamo derivati proprio dall’acquisto di quei preziosi libri che tanto amava e ricercava. Cosimo il Vecchio de’ Medici, nominato tra gli esecutori testamentari, propose il convento di San Marco la cui ricostruzione era stata da poco affidata dai Medici all’architetto Michelozzo; fu proprio per accogliere la raccolta libraria del Niccoli che nel 1441 Cosimo commissionò la costruzione della monumentale Biblioteca, completata nel 1444 e successivamente ampliata con l’aggiunta di un nuovo vano, la Sala Greca.

La Biblioteca del convento di San Marco, custode della raccolta del Niccoli (in seguito incrementata dai Medici e da altri personaggi di spicco), iniziò dunque a svolgere la sua funzione di spazio pubblico, luogo aperto agli studiosi, religiosi e laici che qui potevano condurre le proprie ricerche, incontrarsi e discutere di letteratura, filosofia, teologia. Quella fioritura culturale e figurativa che conosciamo con il nome di Rinascimento non sarebbe stata possibile senza le dotte discussioni che si tenevano in questo importante punto di incontro e centro del sapere.
Oggi della gloriosa Biblioteca di San Marco, così come pensata nel Quattrocento, rimangono solo i superbi spazi. Non ci sono più i banchi lignei e i leggii, non è più presente l’originaria raccolta di codici che l’aveva resa celebre: questa, infatti, tra dispersioni e soppressioni, è confluita parte nelle biblioteche statali fiorentine, parte in biblioteche straniere e in collezioni private. Solo un piccolo nucleo di codici, pervenuti a partire dall’Ottocento da varie sedi, è rimasto a San Marco permettendo alla Biblioteca di portare avanti quella sua antica funzione, così che ancora oggi, nello spazio raccolto, ma non meno suggestivo, della Sala Greca, gli studiosi si trattengono a consultare pazientemente i preziosi codici con la competente assistenza del personale. L’ampia aula della Biblioteca continua invece ad essere luogo di promozione della cultura ospitando conferenze e concerti aperti al pubblico.

A conclusione di questo contributo, preme ricordare che proprio in tempi recenti abbiamo potuto sperimentare direttamente l’inaccessibilità della cultura, pur senza appartenere a quei Paesi in via di sviluppo per i quali il problema persiste da tempo: è accaduto con la chiusura delle biblioteche, imposta a seguito dell’emergenza Covid-19. È presto per valutare quanto questa assenza, seppur temporanea, abbia inciso negativamente sulla vita quotidiana di tutti, non solo di studenti e studiosi. Voglio però ricordare come, presi dalle difficoltà del momento, siamo tornati ad essere un po’ come i nostri cari umanisti, andando a rovistare nelle librerie di casa per ritrovare un testo da cui trarre una citazione, inviando ai colleghi scansioni di saggi non reperibili su Google Libri, scambiandosi (quando ciò è tornato possibile) i libri personali, acquistando on-line i libri necessari, tutto ciò senza smettere di desiderare, come allora, che le biblioteche pubbliche potessero riprendere quanto prima la loro attività. Nel frattempo, sfruttando l’unico canale di comunicazione rimasto aperto, il Web, abbiamo continuato a proporre occasioni di riflessione e di approfondimento culturale attraverso le pagine di questo nostro blog, a dimostrazione che quanto più numerosi sono i canali che si vogliono attivare, tanto più la cultura può ‘viaggiare’ e arrivare alle persone.

Post scriptum:
Un’epidemia di portata mondiale, biblioteche inaccessibili, libri che circolano sottobanco, la realtà parallela del Web, la cultura che comunque non si ferma: gli spunti per un nuovo romanzo di Umberto Eco ci sarebbero stati tutti. La maggior parte dei suoi lettori avrebbe forse immaginato il protagonista con le sembianze del compianto Sean Connery, volto e anima di Guglielmo da Baskerville nel film di Jean-Jacques Annaud tratto dal romanzo Il nome della rosa. Parlando dunque di umanisti e biblioteche, ricordiamo Eco quale straordinario umanista moderno, qui ripreso mentre attraversa la sua immensa biblioteca (a partire dal minuto 4:53):
Per saperne di più:
– Umberto Eco, De Bibliotheca, edizione elettronica a cura di Liber Liber, dove si parla delle biblioteche per “non far leggere”
– Eugenio Garin, La Biblioteca di San Marco, Firenze, Le Lettere 1999 (ristampa del saggio La Biblioteca di San Marco: appendice di documenti pubblicato in La Chiesa e il Convento di San Marco a Firenze, Firenze 1989, vol. I, pp.79-148)
– Sul patrimonio della Biblioteca oggi si rimanda al recente contributo di Ada Labriola nel blog
Credit foto Massimo Listri: Biblioteca Malatestiana (2002); Biblioteca Laurenziana (2009); Biblioteca San Marco (2009)